
Scuola di Psicoterapia: intervistiamo il Prof. Santo Di Nuovo
Intervistiamo il Prof. Santo Di Nuovo: Il ruolo tra Psicoterapia e Medicina
[stextbox id=”info”]Presidente dei corsi di laurea in psicologia nell’Università di Catania, giudice onorario nella Corte d’Appello del Tribunale, sezione minori e famiglia, e presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania. La sua ricerca è centrata sugli aspetti metodologici e psicometrici dello studio degli interventi clinici e riabilitativi, e sull’integrazione fra psicologia e neuroscienze[/stextbox]
1) La psicoterapia può oggi avere un ruolo che si integra con la medicina?
Fin dalle sue origini, a parte alcune radicalizzazioni, la terapia della mente è stata considerata associata a quella del corpo. Il mio maestro, Angelo Majorana, fece stampare sulla carta intestata della sua Clinica ‘Carmide’ la frase presa dall’omonimo dialogo di Platone: “Il corpo non può essere curato senza tener conto dell’anima, perché l’errore è che alcuni si mettono a fare i medici dell’una o dell’altra cosa separatamente, o della saggezza o della salute”.
Corpo e mente sono aspetti della stessa realtà. Quando una persona sta male non è perché si è ammalato un singolo organo del suo corpo o una singola funzione della sua mente, ma perché qualcosa si è alterato ‘globalmente’. E la cura non può che essere altrettanto globale, cioè deve congiungere interventi psicologici e medici.
Oggi l’integrazione fra la psicoterapia e la medicina passa indubbiamente anche attraverso la farmacoterapia, che ha fatto grandi progressi negli ultimi decenni ed ha raggiunto livelli di efficacia ed efficienza tempo fa impensabili.
Non possiamo trascurare che la grande maggioranza di quanti soffrono di ansia o depressione preferisce ricorrere ai farmaci piuttosto che alla psicoterapia. Qualche anno fa un’indagine del Consumer Reports negli Stati Uniti (ma la tendenza è analoga ovunque) ha confermato che 80% dei depressi o ansiosi preferiscono prendere pillole piuttosto che seguire le più lunghe e costose cure psicologiche.
Per quanti dubbi possano restare sull’affidabilità delle ricerche sui farmaci e sull’etica della loro somministrazione, considerando i grossi interessi economici che vi stanno dietro, questo è un dato di fatto da cui non si può prescindere.
D’altra parte è dimostrato da tutti gli studi meta-analitici che l’integrazione di farmacoterapie e terapia psicologica è la più efficace e consente il mantenimento nel tempo dei miglioramenti.
La ricerca psicologica deve tenere conto di questa realtà e studiare le modalità migliori per realizzare una proficua integrazione: poco infatti si sa di certo e definitivo su questi aspetti, e medici e terapeuti si affidano spesso alla routine e al (cosiddetto) buon senso piuttosto che su protocolli validati empiricamente. Su questi aspetti la psicologia può dare un contributo determinante nella cura della sofferenza umana.
2) La ricerca in psicoterapia ha dato risultati utili?
Certamente. Anni di ricerca hanno consentito di accertare, attraverso una serie di studi in cui le variabili in gioco vengono tenute quanto più possibile sotto controllo, se e in che misura le terapie ‘funzionano’ e sono utili per lo scopo proposto per specifiche patologie. A questa convalida relativa all’efficacia, una volta assodato che la psicoterapia è meglio del cosiddetto placebo, si è affiancata la ricerca mirante a spiegare perché un certo processo funziona. La ricostruzione del significato delle variabili in relazione alla complessità del fenomeno studiato si differenzia dall’approccio ‘nosografico’ i cui fini sono prevalentemente pragmatici. Capire perché una persona è portatrice di certi sintomi, e quale significato questi sintomi assumono nella sua vita, è diverso dall’inquadrare i sintomi in una categoria diagnostica, utile al fine di prescrivere una certa terapia piuttosto che un’altra. Analogamente, capire perché una terapia funziona, qual è il senso di ciò che avviene durante essa, come questo senso induce il cambiamento, è diverso dal valutare l’efficacia in termini di riduzione di sintomi o di problemi.
Il monitoraggio continuo del processo terapeutico consente gli opportuni aggiustamenti in itinere, impedendo che la terapia proceda per tempi lunghi su canali poco proficui rispetto alle possibilità. Fornisce inoltre l’opportunità di studiare cosa è terapeutico e per chi; non solo se e quanto ma perché un trattamento funziona con una certa tipologia di pazienti e non funziona invece con altri; quali processi psichici vengono attivati e quali assetti di personalità vengono modificati. Obiettivi essenziali per una psicoterapia che voglia essere non solo congruente al proprio interno e pragmaticamente utile, ma anche aperta al controllo intersoggettivo delle variabili in gioco e della loro relazione con il modello teorico.
L’analisi del processo è oggi riconosciuta come essenziale per la ricerca sulla psicoterapia, ad integrazione della verifica dell’esito finale. Entrambe le tipologie di ricerca sono utili, e su entrambe abbiamo una quantità di dati che gli ‘Handbook’ periodicamente aggiornano, fornendo una panoramica di quanto la ricerca ha trovato finora per rendere sempre più efficace il lavoro del terapeuta.
3) Le varie correnti della psicoterapia potranno pian piano confluire in una svolta di integrazione?
Uno dei risultati più rilevanti della ricerca sulla psicoterapia è quello relativo al rapporto fra “fattori specifici” e “fattori terapeutici comuni” nel determinare l’efficacia del trattamento. Ebbene, si è visto che le tecniche specifiche, relative al tipo di approccio teorico seguito, incidono sugli esiti della terapia solo per il 10%; un altro 10% della spiegazione degli effetti attiene alle caratteristiche del terapeuta, mentre circa il 50% è da attribuire alle variabili del cliente e del contesto in cui egli vive. Il 30% rimanente riguarda quelli che vengono definiti “fattori terapeutici comuni”: relazione positiva, empatia, ‘calore’, rassicurazione, accettazione, possibilità di ‘insight’, esperienza emotiva correttiva, catarsi.
Da questo predominio dei fattori comuni sulle specifiche tecniche bisognerebbe ripartire per una svolta di integrazione fra modelli terapeutici: non mirando ad un “eclettismo” che mette insieme cose diverse, spesso in modo arbitrario, che è il modo più frequente e sbagliato di fare integrazione.
Una inchiesta condotta via web su oltre 2000 terapeuti ha trovato che la maggioranza di essi mescola almeno due orientamenti diversi; analoghi risultati provenivano da un sondaggio condotto negli Stati Uniti, in cui si evidenziava come quasi tutti gli intervistati usavano anche tecniche dedotte da orientamenti diversi da quello riconosciuto come proprio.
Ogni terapeuta può prendere da modelli diverso dal suo ciò che meglio si adatta al caso che ha davanti e al momento specifico della terapia, innestando un approccio (di rinforzo, interpretativo, sistemico, di ristrutturazione di idee disfunzionali, e così via) che non è l’intervento di elezione del proprio modello, ma che in quel caso potrebbe rivelarsi il più adatto.
Per esempio, un terapeuta non può usare lo stesso modello quando lavora nel proprio studio o quando assume incarichi in contesti giuridici o penitenziari. Saprà integrarlo con approcci e tecniche derivanti da altri modelli, ammesso che li abbia conosciuti e studiati?
In realtà siamo ancora lontani da questo tipo di integrazione che dovrebbe avvenire al momento della formazione (continua): diverse ‘scuole’ preferiscono invece arroccarsi dietro le proprie certezze e trasmettere solo queste certezze ai propri adepti. Poi l’integrazione avviene in modo estemporaneo al momento in cui il terapeuta ha davanti un paziente che non risponde come previsto a ciò che quello che egli sa e sa fare, per cui o invia il paziente ad altro terapeuta di orientamento diverso (evento raro) oppure – più spesso – prova interventi diversi per vedere se così una situazione di stallo può essere sbloccata.
Cosa diversa è l’integrazione fra approcci diversi che viene già proposta e insegnata nelle singole scuole di formazione (come teoricamente dovrebbe essere in base alle norme vigenti sulla formazione alla psicoterapia), basandosi su modelli di integrazione adeguatamente verificati dalla ricerca empirica.
La flessibilità, che include il cambiamento di orientamento e prospettiva, è una funzione essenziale di un terapeuta efficace, ma questo cambiamento che si traduce in una adeguata integrazione deve seguire regole scientifiche e non fluttuazioni casuali: essenziale è in questo senso il ruolo della formazione e della supervisione.
Nodi centrali dell’integrazione fra modelli diversi restano naturalmente i “fattori comuni” di cui abbiamo parlato. Che però non comporta sfumare i diversi approcci teorici e metodologici per arrivare ad un minimo denominatore comune (poco utile in quanto appunto“minimo”), ma comprendere che la persona portatrice di disagio e sofferenza è unica e quindi aggredire la sofferenza da diverse strade migliora l’esito finale e il processo per arrivarci.
4) Quali sono le nuove frontiere della Psicoterapia?
Secondo me le frontiere attuali sono quelle che si rivolgono allo studio della relazione terapeutica. Che non è poi una questione nuova, dato che tutti gli approcci terapeutici ne hanno parlato, seppur dando a questa relazione nomi diversi.
È ormai indubbio che il legame tra chi cura e chi è curato, e le conseguenze che questo legame comporta sul piano dell’esperienza della terapia, sono di importanza centrale. Nozioni quali transfert e contro-transfert, self-disclosure, empatia, modalità di attaccamento, compliance, alleanza terapeutica, hanno in comune la capacità del terapeuta e del cliente nell’analizzare direttamente la loro relazione ed i problemi che accadono all’interno di essa, facilitando l’espressione ed accettazione dei sentimenti e il miglioramento della relazione e di conseguenza il trasferimento dei cambiamenti che avvengono in terapia ad altre relazioni fuori la terapia.
L’elemento che accomuna gli aspetti della relazione all’interno di un trattamento è la responsabilità, intesa sia come presa in carico ed equilibrata gestione dei problemi della persona-utente e della relazione, evitando sia chiusure difensive sia cedimenti a scorciatoie manipolatorie; ma anche come piena e costante disponibilità a rispondere dei propri atti, e dei risultati di essi, alla comunità scientifica (apertura alla comunicazione e al confronto) e alla società (aspetti deontologici e giuridici del lavoro professionale).
Su questi aspetti c’è ancora tanto da lavorare, a livello di formazione e di esperienza (supervisione inclusa), e di ricerca: ecco perché considero questa una frontiera ancora aperta della psicoterapia.
5) Come la psicoterapia deve tener conto delle scoperte delle altre discipline che studiano l’uomo?
Oggi la psicoterapia deve tenere conto soprattutto delle scoperte delle neuroscienze. Ma non in modo acritico e subordinato. Riguardo al processo di cambiamento terapeutico, neuroscienze e psicologia possono trovare punti di convergenza, dopo anni di incomprensioni nei quali i litigare sulle origini biologiche o meno delle psicopatologie distoglieva l’attenzione da quanto si può fare in modo convergente per modificarne gli assetti e le conseguenze comportamentali.
Ormai siamo tutti convinti che, come già ricordava Kandel, le patologie psichiatriche non possono essere esito solo di mutazioni genetiche: considerato che 24 mila geni sviluppano 100 miliardi di neuroni e 1015 connessioni, con altrettanti miliardi di possibili variazioni combinatorie, è facile capire come la ricerca genetica sulle malattie mentali dia risultati contraddittori e deludenti.
Lo stesso Kandel, e la ricerca neuroscientifica attuale, ha dimostrato che le psicoterapie agiscono sul funzionamento psicobiologico. Questa conclusione non ci sorprende, se è vero che l’assetto biologico sorregge cognizioni, emozioni e comportamenti e dunque varia al variare di esso, in negativo o in positivo, e che l’aumento di complessità e ricchezza delle connessioni cerebrali e dei collegamenti tra gli emisferi cerebrali e tra le aree funzionali – che la terapia può favorire – corrisponde ad un migliore stato di salute mentale.
La plasticità neuronale e le variazioni epigenetiche (di cui tanto si parla oggi come nuova frontiera delle neuroscienze) consentono possibilità di ristrutturazioni del sistema biologico che la psicoterapia può attivare, al pari dei farmaci ed anzi con effetti più a lungo termine: permettono in definitiva che “il cervello cambi se stesso” come diceva Doidge nel titolo di un suo libro.
Dimostrata empiricamente l’ipotesi secondo cui l’attività terapeutica può cambiare le strutture cerebrali, non ci resta che concludere con LeDoux che essendo la psicoterapia un processo di apprendimento per i pazienti, è di conseguenza un modo di cambiare l’assetto delle connessioni cerebrali. In questo senso, la psicoterapia sostanzialmente coinvolge meccanismi biologici per curare la malattia mentale.
Mi pare questo il punto di convergenza più interessante che riepiloga i punti fin qui trattati: l’integrazione fra mente e corpo, fra psicoterapia e farmacoterapia, fra modelli diversi di psicoterapia, fra ricerca sull’esito e sul processo. E che colloca la psicoterapia, correttamente intesa e insegnata, fra le modalità più utili per intervenire sulla sofferenza umana e riattivare il benessere individuale e collettivo.



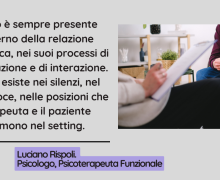







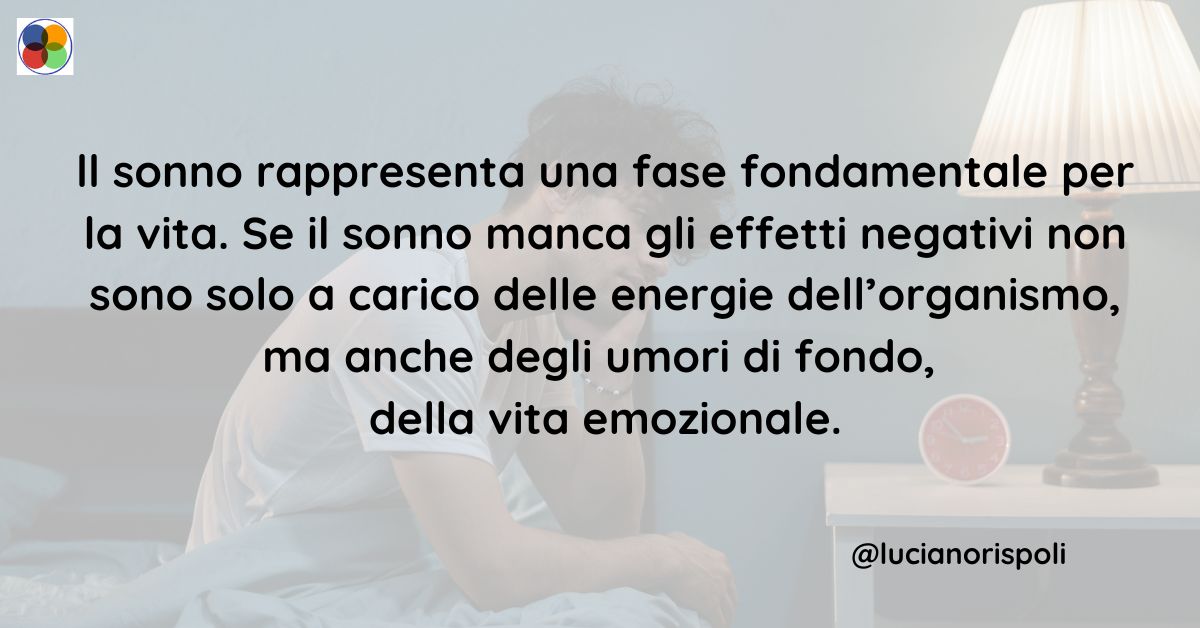











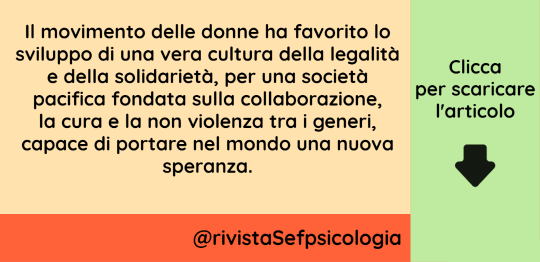
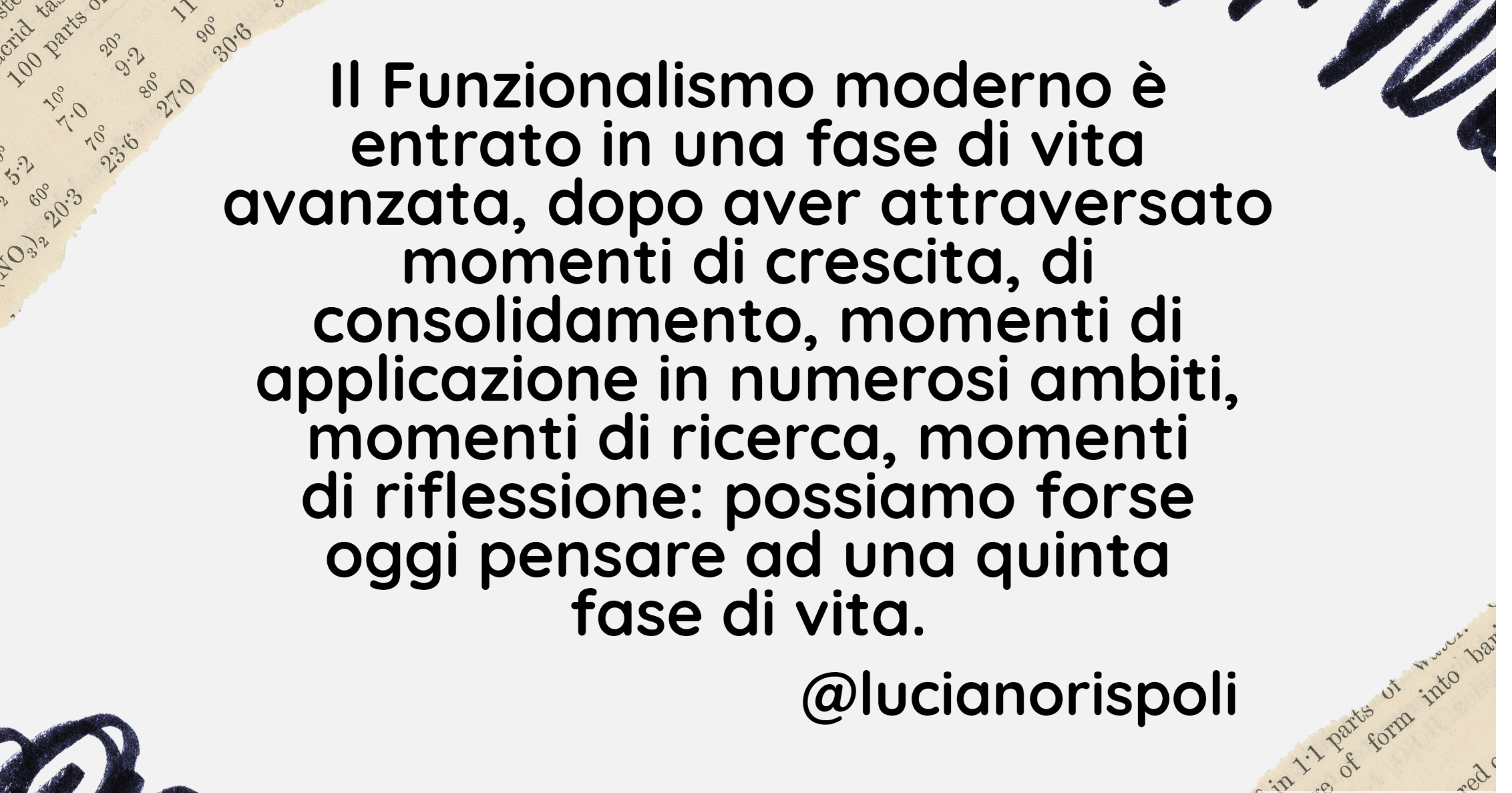


Commenta con il tuo profilo social preferito: